
Chiara Saraceno,
L’equivoco della famiglia,
Laterza, Bari/Roma 2017,
pp. 173, € 15,00
A breve distanza dal libro Mamme e papà (recensito in ISP notizie n. 4/2016) esce un nuovo libro della sociologa Chiara Saraceno. Se nel precedente Saraceno aveva imboccato una strada abbastanza soft, rifuggendo da posizioni estreme (non certo per opportunismo o quieto vivere, ché ben conosciamo la sua verve polemica e battagliera), qui torna a indossare i guantoni – ci perdoni la metafora poco femminile – e a sferrare alcuni “diretti”. Già il titolo suona vagamente provocatorio (ma anche stimolante). In cosa consiste “l’equivoco” per Saraceno? Costretti come siamo a sintetizzare, diremo: nel fatto che la famiglia “appare uno spazio in cui vale il principio del dato per scontato, dell’ovvio, più che del conosciuto e riflettuto”. Così, frasi come “i bambini hanno bisogno di una mamma e di un papà”, o “i padri che fanno i mammi rischiano di impedire ai figli di crescere” o “le madri sono più adatte a prendersi cura dei figli”, o “un bambino soffre se la madre lavora”, o ancora ritenere che riconoscere a coppie dello stesso sesso la possibilità di costituire una famiglia sia in contrasto con la “famiglia naturale”, ebbene tutto ciò – afferma Saraceno – è dato per scontato, vero in sé, indimostrabile nonostante le molte smentite empiriche.
Ce ne sarebbe abbastanza per rinfocolare un bel po’ di polemiche, ma Saraceno aggiunge le radicali differenze storico-sociali che caratterizzano le famiglie pur nell’ambito – relativamente omogeneo – delle attuali società occidentali e le sensibili differenze fra regione e regione nel nostro Paese. E poi ci sono i grandi cambiamenti che negli ultimi decenni hanno caratterizzato la famiglia, italiana e non solo: l’indebolirsi del ruolo del matrimonio (un matrimonio su tre è preceduto da una convivenza) e l’aumento dei secondi matrimoni, con relativa dilatazione del concetto di famiglia per via di figli precedenti e successivi, l’aumento del numero di divorzi.
Sulla inesistenza di una “famiglia naturale” torna più volte Saraceno, per via di “tutte le smentite che provengono dall’antropologia, dalla storia, dai confronti tra paesi, all’idea che l’incapacità di generare come coppia si traduca automaticamente in incapacità di essere genitori (peraltro solo per le coppie dello stesso sesso, e non per le coppia sterili di sesso diverso)”.
Equivoci, a parere della studiosa, anche nella riflessione sulla famiglia da parte della Chiesa cattolica così come è stata elaborata nei due sinodi dei vescovi e riassunta nel documento del pontefice Amoris Laetitia (e che lo spazio non ci consente di illustrare).
Nel capitolo “Nuove madri, nuovi padri” si sottolinea lo scarso aiuto da parte di questi ultimi nel lavoro domestico (siamo d’accordo), nella cura dei figli (lo siamo un po’ meno) e in quella delle persone parzialmente non autosufficienti (di solito è così), “anche se le cose sono in lento cambiamento”. I padri sono “vittime come le madri di modelli di genere” che soffocano la potenziale ricchezza degli esseri umani. E la paternità – come andiamo affermando da anni in termini ancor più radicali – “è la dimensione dell’identità sociale e individuale maschile che forse, nelle società sviluppate, ha conosciuto più cambiamenti da cinquant’anni a questa parte”.
E le mamme? Saraceno ne prende le difese con decisione: “sono insieme tra le più denigrate per quanto succede ai loro figli (dall’accusa di mammismo, che impedirebbe ai figli di diventare autonomi, a quella di narcisismo se appena distolgono lo sguardo da quello che viene loro assegnato come compito principale, se non esclusivo) e le meno sostenute nella vita quotidiana”. Personalmente, non ci sentiremmo di muovere la seconda accusa, ma ci sembra difficile non sostenere quella di mammismo, con un buon numero di conseguenze. Quasi un secolo fa, nel 1916, l’analista “selvaggio” (come si definiva) Georg Groddeck affermava che la madre “è indispensabile per la vita umana, ma, a causa del senso di reponsabilità, è terribilmente opprimente ed è diventata un pericolo assoluto” perché “non riesce ad abituarsi all’idea che i figli diventino autonomi e a non esserne più responsabile” (ed erano, figuriamoci, mamme tedesche!). Quarant’anni dopo la scrittrice Elsa Morante fa definire al Wilhelm Gerace dell’isola di Arturo la madre “parassita eterno”, che “vorrebbe sempre tenerti prigioniero, come al tempo ch’era incinta di te”. Due citazioni, fra le infinite possibili, di un fenomeno che è schiettamente mediterraneo ma è anche iscritto, crediamo, nel codice genetico (e morfologico) della donna.
Molti altri argomenti sono affrontati nel libro: dai single alle famiglie transnazionali, dall’aborto ai congedi parentali, dall’affido condiviso all’adozione, dalla riproduzione assistita alla teoria del genere, agli anziani… Su ogni argomento, posizioni chiare, senza ambiguità e senza sfumature. Sulle quali, naturalmente, si può essere d’accordo o meno. Per esempio non condividiamo molto l’affermazione secondo la quale le madri separate e divorziate “sono a rischio povertà”: almeno a breve termine il rischio povertà attende piuttosto i padri. E non è un caso che alcune Caritas (fra le quali quella di Torino, città di Saraceno) abbiano inserito espressamente i padri separati fra i “nuovi poveri” che ad esse fanno ricorso e non le madri. E ancora: siamo d’accordo sul fatto che la tenerezza dei “nuovi padri” possa conciliarsi con l’autorevolezza e che un padre accudente non sia “automaticamente permissivo, debole, in fuga dalle proprie responsabilità”; e tuttavia il problema dell’autorevolezza non nasce tanto in rapporto con l’accudimento (che rimanda a bambini in tenera età), quanto con l’essere padre-amico in una età particolare, quella dell’adolescenza.
Totalmente d’accordo quando Saraceno scrive che “la lenta avanzata dei padri accudenti è un fenomeno da incoraggiare senza ambivalenze”. Per una pari opportunità – osserva la sociologa – : “per far sì che le madri possano conciliare meglio lavoro di cura e lavoro per il mercato (e magari anche un po’ di tempo per sé), ma anche perché venga riconociuta la legittimità del desiderio di molti padri di avere più tempo per i figli, di sperimentare l’intensità relazionale che si dà nella cura di un bambino piccolo…” ecc. Noi avremmo invertito l’ordine delle opportunità, ma questa è una debolezza che sarà perdonata ad entrambi: sia chi scrive questa recensione che l’autrice del libro, infatti, guardano allo stesso problema da un punto di osservazione leggermente diverso…
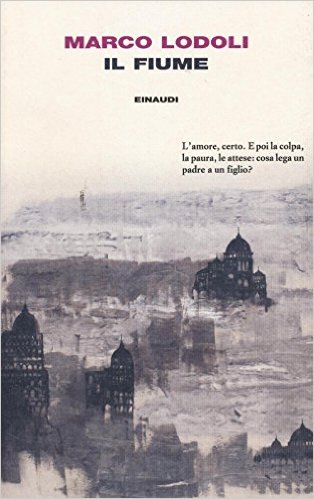
Marco Lodoli,
Il fiume,
Einaudi, Torino 2016,
pp. 101, € 14,50
Il fiume del titolo è il Tevere, lungo il quale Alessandro – padre separato e non per sua decisione – ha portato Damiano, il figlio di dieci anni, a camminare un po’. Hanno lasciato il circolo del tennis nel quale, poco prima, hanno giocato un doppio. Più tardi Alessandro ricondurrà il bambino a casa, dalla madre. Ancora qualche ora, questa è la sua domenica, la domenica che gli spetta. Il bambino cammina davanti, sulla banchina, si sporge a osservare un’anatra, “ferma in quell’acqua fetida”. L’uomo lo segue di qualche passo, la mente spazzata da immagini frammentate e scomposte che vengono da lontano e “si posano come uccelli neri sul filo della biancheria, quando tutti i panni puliti sono ritirati”. Sono immagini che arrivano “quando da solo, la domenica sera cerca qualcosa da da fare e non trova nulla che valga la pena”. Lui vorrebbe respingerle, ma quelle “si moltiplicano, si accoppiano, procreano”.
E in un attimo il figlio non c’è più, inghiottito dall’acqua scura: “Il fiume ha aperto la bocca e ha bevuto il bambino”. E lui, il padre, è come paralizzato. Fermo come un sasso – sono le parole di Lodoli – braccia annodate sul petto, gambe conficcate nella terra, “come addormentato nell’aria stupida della domenica”. Ma qualcuno si tuffa e riemerge, una, due, tre volte. Ha fra le braccia il bambino, lo spinge verso la banchina, verso la gente che si è assiepata con angoscia. Damiano respira, è vivo, il suo salvatore è scomparso. Alessandro vorrebbe tornare subito a casa, dimenticare e far dimenticare al figlio l’accaduto. Damiano no, lui vuole trovare quell’uomo che si è tuffato e lo ha riportato alla vita. Non parla molto, vuole solo quell’uomo. Ma per Alessandro è come se dal figlio sgorgassero torrenti di parole: accuse terribili, rimproveri che lo feriscono e lo mettono di fronte a se stesso, alla sua paura, alla sua debolezza, alla sua vergogna, “scavano nella carne fragile, sabbia asciutta e tenuta insieme solo da uno sputo”.
Comincia così un viaggio nella sera, e poi nella notte, alla ricerca del misterioso soccorritore. Viaggio allucinante e allucinatorio, che porta il padre fra i saloni del palazzo di una vecchia marchesa ingioiellata, ossuta e inferma dove si svolge una festa per poveri adulti dementi, in una roulotte che ospita un gigantesco transessuale, nel letto di una prostituta, in un circo dove sta per cominciare un numero speciale allestito per tre soli spettatori: un bambino cieco e i suoi genitori, in un barcone deserto agganciato alla sponda del fiume. Una Roma persa e lontana, dalla dimensione onirica e surreale, con personaggi strampalati e poco credibili che ricordano certe figure felliniane o quelle del viaggio di Alice nel suo fantastico paese.
Il viaggio non serve solo a cercare un uomo generoso (alla fine lo troverà? Forse si, ma il dubbio rimane, perché ormai nel peregrinare notturno di Alessandro realtà e allucinazione, falso e vero e verosimile si confondono); serve ad Alessandro per cercare qualcosa di sé, del suo passato, del suo vero essere, serve a fare i conti con se stesso. Lampi di una volta scandiscono il suo vagare: la nascita di Damiano, il primo amore, il primo sesso, e poi le sue amanti, il suo lavoro e i suoi clienti, il suo ufficio. E’ una ricerca svagata e dolorosa, che nemmeno le telefonate rabbiose e piene di ansia della madre di Damiano sembrano riportare a una dimensione reale.
Sarà vero – come abbiamo letto in una recensione – che Alessandro rappresenta “una generazione di padri inaffidabili, fragili, inadeguati”? Forse è solo un uomo (e chi ha detto che i padri devono invece essere superuomini?) con le sue paure e le sue difficoltà. Certo, agli occhi di un bambino suo padre deve essere capace di tutto e naturalmente di salvarlo se è in pericolo di vita.
Alla fine – forse è qui la vera metafora del libro – il padre reale ha fallito il suo compito, ma quello ideale è troppo forte per deludere Damiano. Ed è il bambino, al termine di quella orribile notte, che ritrova e perdona suo padre:
– Ho sognato che ero caduto nel fiume (…) Sono rimasto tanto tempo sott’acqua, ti ho aspettato per ore.
– E poi cosa è successo?
– Poi tu sei arrivato e mi hai salvato.
